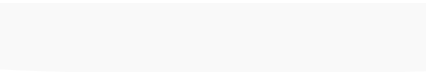Intervista a Silvia Ballestra: "I giorni della Rotonda"
San Benedetto del Tronto | Al di là di delle divergenti visioni e opinioni, alcuni passaggi del romanzo riescono in modo efficace a rimandare al presente un atmosfera, un comune sentire che di quel tempo costituisce unimpronta difficilmente contestabile.
di Maria Teresa Rosini

Silvia Ballestra
C'è un po' di autovoyerismo nel leggere in un romanzo una parte della propria vita, i luoghi, le persone, i fatti che hanno costruito le trame della nostra stessa esistenza e che, in qualche modo, ci hanno resi quelli che siamo.
Ma Silvia Ballestra compie un viaggio che è innanzitutto suo: sono suoi gli occhi che hanno visto, raccolto e interpretato quel territorio così "liquido" e indefinibile che è il passato. E lo hanno filtrato soprattutto attraverso quello che il passato ha costruito in lei e che ha indirizzato il suo sguardo. Sembra quindi azzardato contestare uno sguardo, un'esperienza anche se a volte il nostro sguardo può non riuscire a sovrapporsi al suo.
Mi sembra invece che, al di là di delle divergenti visioni e opinioni e dal momento che si tratta di un romanzo, si possano apprezzare e condividere alcuni passaggi che riescono in modo efficace a rimandare al presente un' atmosfera, un comune sentire che di quel tempo costituisce un'impronta difficilmente contestabile e che è opportuno sottolineare senza perdersi in inutili battibecchi su singoli fatti e circostanze.
Mi è piaciuto il modo semplice ma efficace col quale hai brevemente e semplicemente tratteggiato lo spirito che animava i ragazzi della Rotonda negli anni settanta: "...Volevano fare qualcosa per rendere il mondo, anche lì da loro, più giusto e più dignitoso, meno bigotto e meno arretrato.... Per ottenere queste cose erano disposti a fare delle lotte e a pagarne gli scotti in prima persona....Al fondo c'era questo sincero interesse per gli altri". Lo spirito che ha animato questi giovani è qualcosa che nelle diatribe accanite sugli anni settanta viene considerato un elemento spesso secondario. Tu cosa ne pensi?
Purtroppo in generale nei discorsi sugli anni settanta prevale il dibattito attorno alla violenza: non a caso l'etichetta che ha avuto più fortuna nell'immaginario collettivo e nella costruzione di una memoria su quel periodo è quella di "anni di piombo". Le cose buone e positive di quel periodo - grandi e importanti - vengono come annullate dalla piega dolorosa che hanno preso certi eventi. Invece, quel che appariva naturale e scontato, l'altruismo, lo slancio verso un mondo migliore e più giusto per tutti, oggi sono merce rara. Dopo gli anni Ottanta, e poi i Novanta, e poi gli anni zero del nuovo millennio, sembra molto più scontato pensare al proprio orticello e a mettersi al riparo ognuno per proprio conto, pensare solo per sé, mentre, a guardare la storia e le storie di quegli anni, colpisce proprio lo spirito profondamente diverso: ma la repressione non è mica passata invano... Pagare in prima persona, prima di tutto: oggi ci si penserebbe venti trenta volte, proprio alla luce di quello che successe allora. E poi ho scelto di presentare i ragazzi della Rotonda in questo modo per evitare di impelagarmi in frammentazioni e discussioni che avrebbero portato altrove, e dunque cercando di capire cosa ci fosse al fondo, cosa potesse accomunare le diverse esperienze.
L'epopea dei marinai sambenedettesi, la fatica per ottenere il riconoscimento di diritti, la perseveranza e la determinazione con cui questi giovani li hanno affiancati nelle lotte è un patrimonio da recuperare alla città. Nel racconto è soprattutto attraverso il personaggio di Domenico che tutto questo viene raccontato. In realtà hai sentito su questo argomento molti testimoni o hai scelto di affidarti in modo particolare al racconto di uno (il Domenico tra l'altro facilmente riconoscibile)?
Domenico è stato prezioso perché incarna la cerniera fra la piazza e il porto. Fra l'antifascismo e la lotta applicata alla conquista di una cosa grande e importante (il contratto nazionale dei marinai). Domenico è anche colui che racconta - e i marinai in questo sono maestri, la letteratura appare appena nomini il mare e le barche - e tiene i fili fra le generazioni. Il vero Domenico è stato (ed è) indiscutibilmente un soggetto molto attivo, pieno di sollecitazioni e poi non è così frequente che a parlare siano quelli che lui chiamerebbe i proletari: voglio dire, si sa che a scrivere e raccontare sono più di frequente i borghesi (l'alfabetizzazione di massa in Italia risale a poche generazioni fa e non siamo certo gli Stati Uniti dove moltissimi outsider hanno accesso alla pubblicazione). Sono d'accordo che l'epopea della marineria sambenedettese vada valorizzata: pur essendo cresciuta a pochi passi da via Laberinto e avendo ricordi di visite scolastiche a bordo dei nostri pescherecci atlantici (mitico l'ingresso in sala macchine), io stessa ne sapevo pochissimo.
E' stato anche molto importante seguire le tracce di Renato Novelli, naturalmente, pur non andando a interrogarlo direttamente (un po' per questioni di tempo e occasioni, un po' perché ha scritto ottime cose). La sua testimonianza in "Lotta continua" di Corrado Sannucci è stata importantissima e poi è un racconto bellissimo, scritto con grande affetto e ironia. Avevo già trovato delizioso il suo "Brodettogonia" uscito qualche anno fa, e insomma Renato è una figura fondamentale per la nostra storia e la nostra cultura: mentre scrivevo, in molti mi hanno detto "la mia coscienza politica è nata ai tempi del Rodi grazie a Renato Novelli".
Nel romanzo i ragazzi più giovani della rotonda si sono formati sui racconti dei più "vecchi": la sensazione che si trasmette è che però ci fosse già in atto una trasformazione, che si fosse scivolati dalla consapevolezza politica verso un'ansia disordinata e irresponsabile di risultati. In questo ha sicuramente giocato un ruolo la impossibilità di trovare spazi politici adeguati a rappresentare le aspirazioni di una generazione. Hai avvertito questa distanza tra i ragazzi dei primi anni settanta e i loro "fratelli" minori ascoltando i testimoni?
Secondo me è illuminante leggere "Le vie di Armandino" di Maria Teresa Antonelli, testo fondamentale per capire dalla vivavoce dei protagonisti i sentimenti fra le diverse generazioni che si sono succedute in quel decennio. Lì, leggendo fra le righe, si capiscono le opinioni (spesso dolorosamente critiche) che hanno gli uni nei confronti degli altri. Questo succedersi e mutare di panorama - politico, umano, culturale - è un movimento che nel mio libro è rispecchiato dal montaggio di tre diverse fasi molto staccate: avrei potuto uniformare il tutto con espedienti più classici, ma volevo proprio mostrare il progressivo svuotamento di tante esperienze, la perdita della dimensione collettiva. Comunque non è una storia solo sambenedettese, credo si possa tranquillamente applicare a quello che è successo al Paese tutto.
C'è un efficace salto di atmosfera tra il primo e il secondo movimento: è il privato e la questione femminile che ho letto abbastanza chiaramente nella vicenda del rapporto tra Mari e Marco e in quelle laterali. Tu che sei comunque una testimone di quel periodo, cosa ricordi fosse rimasto del passato e cosa fosse andato invece irrimediabilmente perso? Un privato claustrofobico chiuso in interrogativi personali privo di prospettive in cui la droga che arrivava a fiumi fu il sigillo apposto a chiudere un'epoca: ti sembra un'efficace rappresentazione della realtà di allora?
Non so rispondere: sicuramente c'erano le conquiste delle donne, le conseguenze di questa enorme rivoluzione che fu la liberazione sessuale. Le ragazze si trovavano improvvisamente a gestire nuovi ruoli che comportavano una consapevolezza e una condizione del tutto nuove e i ragazzi (oggi come allora) furono colti alla sprovvista. Ma tutti (questo è un dato universale) si rapportano con certe esperienze con il timore e lo stupore di sempre. La prima volta è sempre la prima volta, anche quando non succede niente.
Qualcuno ha sostenuto che il fenomeno della droga a San Benedetto non fu in realtà così pervasivo e distruttivo rispetto alla realtà generale del paese. A me sembra invece che fu di entità rilevante rispetto alla realtà della città (che era ancora una piccola città di provincia) e fagocitò coloro che erano più sprovvisti di prospettive, di appigli, che non si riconoscevano nella società edonistica e rampante che andava delineandosi e non trovarono alternative. Li descrivi molto bene. La droga sostituì la politica?
Sì, più d'uno l'ha letto così e dunque mi fido. Ma io in realtà pensavo alla diffusione dell'eroina come a un colpo di coda delle repressione esercitata su una generazione. Il movimento capì molto bene, da subito, il pericolo rappresentato dagli spacciatori di eroina: intanto i ragazzi più politicizzati avevano delle informazioni (facevano essi stessi controinformazione sulle droghe: non a caso il protagonista della prima parte conosce bene l'Enciclopedia psichedelica edita da un editore sambenedettese trapiantato a Roma) e a San Benedetto tentarono inutilmente di tenere l'eroina lontano dalla Rotonda. Poi, certo, fu molto funzionale al potere la diffusione di questa droga che è un sedativo, che riduce le persone ai minimi termini. So che è difficile sostenerlo, perché la gente sceglieva di farsi le pere, non era mica obbligata, però l'ignoranza, la ricchezza (ricordiamoci che proprio in quegli anni San Benedetto vive il suo boom, uno sviluppo repentino legato alla pesca e al turismo), il consumismo d'ogni tipo di merce, si sono incontrate col disagio, con la leggerezza, con la ricerca del piacere. Anche qui, non è una storia solo nostra, anzi. Basta parlare con chiunque abbia vissuto quegli stessi anni. Però ci sono state piazze, luoghi, più colpiti di altri. E' un po' difficile negarlo, credo.
Nel libro è anche interessante il linguaggio che riprende il dialetto del luogo, ma anche il gergo giovanile in un mix fluido che dà il senso di una modernità che mantiene un legame con le parole più antiche, con il parlare dialettale dei padri e dei nonni che però quasi scompare nelle ultime due parti del libro. Questo rappresenta anche la scomparsa di radici? La prospettiva con cui si chiude il libro è il futuro, l'università, il lavoro, le poche persone care, l'amicizia.... La condivisione, l'agire collettivo, la politica sembrano non essere più tra le aspirazioni dei giovani della tua generazione . E' stato davvero così?
No, la scomparsa del dialetto nelle ultime parti è dovuta semplicemente a un variare delle storie. Se devo parlare di marinai è chiaro che ci sarà un po' più di dialetto perché gli scambi avvengono in lingua e questa lingua aiuta a rendere più efficaci alcuni passaggi ("l'Autonomia era rattattù" secondo me spiega bene un clima, una certa felicità, anche). Leggendo il libro di Pier Cesare Gobbi mi ha poi colpito come i marinai inventassero dei nomi per i pesci che non conoscevano, mi piace questa creazione spontanea: ho copiato quella lista e l'ho riportata sfoltendola un po' nella seconda parte. Sono nomi in italiano, comunque. Ma il dialetto da sempre è usato dai giovani in modo molto ludico, affettuoso, non solo da noi, ovunque. A volte riflettere su una parola in dialetto che non si conosce significa avvicinarsi a qualcosa che non è possibile rendere in italiano, oppure scoprire sfumature che sono depositate al fondo, dalla notte dei tempi. La parola mozza, per esempio: io ho raccontato quanto tempo ci ho messo a capire da dove veniva.
La prospettiva con cui si chiude il libro è la partenza, il trasferimento altrove, la fuga. Questo temo sia molto attuale e non un fatto generazionale: è la reazione a un paese che non vuol bene ai suoi figli, che non li valorizza e non fa spazio. E mi rendo conto che sto parlando dell'Italia di oggi, non della San Benedetto degli anni Ottanta.
Per ulteriori approfondimenti visitare il sito di Silvia Ballestra http://www.silviaballestra.it/
|
|
17/12/2009
Altri articoli di...
San Benedetto
Una serata di emozioni e scoperte (segue)
Studenti omaggiano il Milite Ignoto (segue)
Samb: Serafino è il nuovo presidente! (segue)
Istituto Professionale di Cupra Marittima: innovazione a tutto campo. (segue)
Open Day a Cupra Marittima, al via il nuovo corso Web Community – Web Marketing (segue)
GROTTAMMARE - ANCONITANA 1 - 3 (segue)
SAN MARCO LORESE - GROTTAMMARE 1 - 0 (segue)
UGL Medici:"Riteniamo che gli infermieri e i medici debbano essere retribuiti dalla ASUR5" (segue)
Le strade musicali dell'Ebraismo nel compendio cinematografico di David Krakauer

Una serata di emozioni e scoperte

Betto Liberati