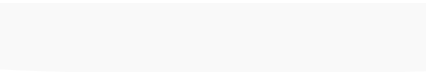Domani notte si brinda in tutta Italia con Calici di Stelle
| Il 10 agosto in 200 Città del Vino una degustazione collettiva che idealmente unisce il Paese. In decine di Comuni la raccolta firme per la petizione Legambiente/Città del Vino contro i trucioli di legno. Battesimo di Roma per Calici di Stelle.
Domani sera occhi al cielo per oltre 400 mila enoturisti in tutta Italia, nelle piazze e nei giardini di circa 200 Città del Vino. Il 10 agosto torna infatti Calici di Stelle, la più importante e affascinante manifestazione enogastronomica dell’estate, una grande degustazione collettiva che idealmente unirà l’Italia del vino da nord a sud in una notte veramente magica, dall’atmosfera particolare, la notte di San Lorenzo. Una notte che sarà animata dalle più svariate iniziative, tante quante i Comuni che partecipano, chi con la musica, chi con le fiaccolate in montagna, chi con il teatro, a questa rinnovata edizione di Calici di Stelle.
Sono due le più importanti novità dell’edizione 2006: il debutto di Roma, che guiderà idealmente Calici di Stelle dalla Casina delle Rose, a Villa Borghese; e la raccolta firme per la petizione Città del Vino/Legambiente contro l’uso dei trucioli di legno per “aromatizzare” i vini con un “finto effetto di legno”, in breve tempo e con pochi soldi, ben altra pratica rispetto al consueto, più impegnativo e dispendioso affinamento in botte. Saranno decine le Città del Vino che hanno organizzato i punti di raccolta; a Roma negli spazi interni della manifestazione, nei pressi dei numerosi banchi d’assaggio aperti al pubblico.
Mentre le notti romane saranno dedicate ai vini e ai prodotti dell’enogastronomia del Lazio, grazie alla collaborazione con Enoteca regionale “Palatium” e Associazione Vigne del Lazio, negli altri Comuni si celebrerà il rito del vino e delle stelle con iniziative originali. A Castelnuovo Berardenga (Siena) è prevista una grande cicloturistica all’interno di un programma che copre tre giornate; a Volta Mantovana (Mantova) uno spettacolo sui miti che raccontano la nascita delle costellazioni; a Morgex (Aosta) una rappresentazione teatrale sulle “leggende valdostane e di montagna”; a Mondragone (Caserta) la “notte bianca dell’arte” con chiese e monumenti aperti fino a notte fonda; a Linguaglossa (Catania) “stelle e vini alla luce del vulcano”, con degustazioni a 1.800 metri sull’Etna e una splendida fiaccolata montanara.
“Calici di Stelle – commenta Floriano Zambon, il presidente dell’Associazione Città del Vino – è uno dei principali eventi del turismo del vino in Italia, un comparto che conta ormai oltre 4 milioni di enoturisti e 2,5 miliardi di € di giro d’affari annuo. E’ una manifestazione che cresce anno dopo anno, è un ottimo canale per promuovere i nostri territori, meta di un turismo di qualità, ma anche per spiegare ai consumatori il grande inganno del vino ai trucioli, secondo una pratica enologica in uso nei nuovi Paesi produttori di vino e che nei prossimi mesi potrebbe essere impiegata anche in Europa”.
Calici di Stelle è organizzata da Associazione Nazionale Città del Vino, Unione Italiana Astrofili e Movimento Turismo del Vino. L’elenco delle Città aderenti e il relativo programma è disponibile sul sito www.cittadelvino.it .
L’origine delle “stelle cadenti”.
Nei secoli passati alle meteore e alle comete fu attribuita un’origine atmosferica, accomunandole a fenomeni meteorologici come tuoni e fulmini. Le leggi cosmiche che, secondo le teorie aristoteliche, descrivevano un Universo immutabile con i vari oggetti del cielo confinati nelle rispettive “sfere celesti”, non potevano ammettere l’esistenza di corpi che potessero attraversare diverse sfere o addirittura cadere sulla Terra. Nell’antichità all’apparizione di comete e di piogge di meteore era attribuito un significato infausto. Le “stelle cadenti” erano interpretate in genere come lacrime di divinità. Ne rappresentavano quindi la disperazione in occasione di epidemie, battaglie sanguinose, stragi e annunciavano la caduta o la morte di re e imperatori. La tradizione popolare cristiana ha ereditato il significato degli sciami di meteore come “lacrime che cadono dal cielo”, legando indissolubilmente le “stelle cadenti” di agosto al martirio di San Lorenzo.
Solo nel corso del XIX secolo gli astronomi compresero l’origine extraterrestre di questi corpuscoli che si illuminano al contatto con la nostra atmosfera. Virginio Schiaparelli, uno dei maggiori astronomi italiani dell’epoca – noto per la sua teoria sulla presunta esistenza dei “canali di Marte” – per primo comprese, nel 1866, l’origine delle meteore dello sciame delle Perseidi. Studiandone i parametri orbitali comprese che erano generate da corpuscoli disseminati dalla cometa Swift-Tuttle. Le Perseidi non sono che uno dei numerosi sciami meteorici che periodicamente hanno un incontro ravvicinato con il nostro pianeta. Anch’essi sono nubi di particelle in massima parte costituite da residui della disintegrazione progressiva delle comete. Queste a ogni loro orbita si ritrovano a passare nelle vicinanze del Sole. Il calore della nostra stella provoca la sublimazione di parte del ghiaccio che costituisce gran parte del nucleo delle comete. A ogni passaggio ravvicinato le comete perdono quindi una certa quantità della propria massa, disgregandosi più o meno velocemente a seconda dell’entità della minima distanza dal Sole raggiunta e alla frequenza dei passaggi. Le comete di corto periodo si “consumano” quindi più velocemente di quelle con orbite molto ampie che tornano a visitare il sistema solare interno solo dopo secoli o millenni. Le particelle cometarie dapprima si disperdono nelle vicinanze della nucleo e, col passare del tempo si distribuiscono lungo tutta l'orbita. Questi "sciami" di piccoli frammenti, quando lungo la propria orbita intersecano quella terrestre, sono all’origine di molte piogge meteoriche.
Lo sciame meteorico delle Perseidi
Il nome di "Perseidi" è legato alla posizione sulla volta celeste del punto - detto "Radiante" - dal quale paiono provenire le meteore, situato nella costellazione del Perseo. Le “stelle cadenti” che generano le Perseidi sono in realtà residui della disintegrazione progressiva della cometa Swift-Tuttle. Nubi di piccole particelle, scontrandosi a gran velocità con l'atmosfera terrestre, danno luogo a una scia luminosa.
Nell'800 il massimo della loro frequenza avveniva il 10 agosto, giorno della ricorrenza di San Lorenzo, ma ai giorni nostri il massimo si è spostato in avanti di circa due giorni. Le Perseidi sono visibili da metà luglio fino a dopo metà agosto, ma mostrano il maggior numero di meteore dal 10 al 13 agosto, con un culmine che in genere ha luogo il giorno 12, quando la Terra nel suo percorso orbitale intercetta la parte più densa dello sciame di particelle. La possibilità di osservare un maggior numero di Perseidi si ha quando il radiante, nel caso specifico la costellazione del Perseo, è più alto nel cielo, cosa che ad agosto avviene nella seconda parte della notte. In Italia potremo cominciare a osservare il radiante verso le ore 22, dapprima basso sull'orizzonte e quindi via via sempre più alto fino all'alba. Il momento della massima attività dello sciame è prevista quest'anno nelle ore centrali della notte tra il 12 e i 13.
In teoria il massimo numero di meteore sarebbe osservabile nella seconda parte della notte – quando il Perseo si trova ben alto sull’orizzonte. Purtroppo quest’anno la Luna recherà un notevole disturbo. L’eccessiva luminosità del nostro satellite naturale impedirà di percepire le meteore più deboli.
Il giorno di luna piena è il 9 agosto e per tutta la notte il disco lunare rischiarerà la volta celeste. Giorno dopo giorno la Luna sorge un po’ più tardi. Quindi il 12 avremo a disposizione le prime ore della sera prima che la Luna, ormai alta nel cielo, inizi a disturbare le osservazioni delle meteore e degli oggetti meno luminosi della volta celeste. Sulla base di queste considerazioni, possiamo augurarci che le Perseidi 2006 siano, come del resto nei passati anni, numerose e abbastanza luminose, e sperare così di arrivare a osservarne alcune decine, specie nelle due ore centrali della notte.
Per chi prenderà parte alle serate astronomiche la luna stessa sarà comunque oggetto di mirabili osservazioni che al telescopio riveleranno gli spettacolari dettagli dei crateri, delle montagne e dei “mari” selenici.
Consigli utili per osservare le "stelle cadenti"
Il modo migliore per osservare una pioggia meteorica è quello di recarsi in un luogo che abbia una buona trasparenza atmosferica e sia lontano dalle luci artificiali, fuori città, possibilmente in collina o in montagna. Occorre assumere una posizione piuttosto distesa e comoda, esempio su una sedia sdraio, e mantenere lo sguardo verso il cielo. La direzione preferibile verso cui guardare nel caso delle Perseidi è verso est nella prima parte della notte e verso sudest o sud nella seconda metà della notte, circa a metà cielo di altezza.
Sono due le più importanti novità dell’edizione 2006: il debutto di Roma, che guiderà idealmente Calici di Stelle dalla Casina delle Rose, a Villa Borghese; e la raccolta firme per la petizione Città del Vino/Legambiente contro l’uso dei trucioli di legno per “aromatizzare” i vini con un “finto effetto di legno”, in breve tempo e con pochi soldi, ben altra pratica rispetto al consueto, più impegnativo e dispendioso affinamento in botte. Saranno decine le Città del Vino che hanno organizzato i punti di raccolta; a Roma negli spazi interni della manifestazione, nei pressi dei numerosi banchi d’assaggio aperti al pubblico.
Mentre le notti romane saranno dedicate ai vini e ai prodotti dell’enogastronomia del Lazio, grazie alla collaborazione con Enoteca regionale “Palatium” e Associazione Vigne del Lazio, negli altri Comuni si celebrerà il rito del vino e delle stelle con iniziative originali. A Castelnuovo Berardenga (Siena) è prevista una grande cicloturistica all’interno di un programma che copre tre giornate; a Volta Mantovana (Mantova) uno spettacolo sui miti che raccontano la nascita delle costellazioni; a Morgex (Aosta) una rappresentazione teatrale sulle “leggende valdostane e di montagna”; a Mondragone (Caserta) la “notte bianca dell’arte” con chiese e monumenti aperti fino a notte fonda; a Linguaglossa (Catania) “stelle e vini alla luce del vulcano”, con degustazioni a 1.800 metri sull’Etna e una splendida fiaccolata montanara.
“Calici di Stelle – commenta Floriano Zambon, il presidente dell’Associazione Città del Vino – è uno dei principali eventi del turismo del vino in Italia, un comparto che conta ormai oltre 4 milioni di enoturisti e 2,5 miliardi di € di giro d’affari annuo. E’ una manifestazione che cresce anno dopo anno, è un ottimo canale per promuovere i nostri territori, meta di un turismo di qualità, ma anche per spiegare ai consumatori il grande inganno del vino ai trucioli, secondo una pratica enologica in uso nei nuovi Paesi produttori di vino e che nei prossimi mesi potrebbe essere impiegata anche in Europa”.
Calici di Stelle è organizzata da Associazione Nazionale Città del Vino, Unione Italiana Astrofili e Movimento Turismo del Vino. L’elenco delle Città aderenti e il relativo programma è disponibile sul sito www.cittadelvino.it .
L’origine delle “stelle cadenti”.
Nei secoli passati alle meteore e alle comete fu attribuita un’origine atmosferica, accomunandole a fenomeni meteorologici come tuoni e fulmini. Le leggi cosmiche che, secondo le teorie aristoteliche, descrivevano un Universo immutabile con i vari oggetti del cielo confinati nelle rispettive “sfere celesti”, non potevano ammettere l’esistenza di corpi che potessero attraversare diverse sfere o addirittura cadere sulla Terra. Nell’antichità all’apparizione di comete e di piogge di meteore era attribuito un significato infausto. Le “stelle cadenti” erano interpretate in genere come lacrime di divinità. Ne rappresentavano quindi la disperazione in occasione di epidemie, battaglie sanguinose, stragi e annunciavano la caduta o la morte di re e imperatori. La tradizione popolare cristiana ha ereditato il significato degli sciami di meteore come “lacrime che cadono dal cielo”, legando indissolubilmente le “stelle cadenti” di agosto al martirio di San Lorenzo.
Solo nel corso del XIX secolo gli astronomi compresero l’origine extraterrestre di questi corpuscoli che si illuminano al contatto con la nostra atmosfera. Virginio Schiaparelli, uno dei maggiori astronomi italiani dell’epoca – noto per la sua teoria sulla presunta esistenza dei “canali di Marte” – per primo comprese, nel 1866, l’origine delle meteore dello sciame delle Perseidi. Studiandone i parametri orbitali comprese che erano generate da corpuscoli disseminati dalla cometa Swift-Tuttle. Le Perseidi non sono che uno dei numerosi sciami meteorici che periodicamente hanno un incontro ravvicinato con il nostro pianeta. Anch’essi sono nubi di particelle in massima parte costituite da residui della disintegrazione progressiva delle comete. Queste a ogni loro orbita si ritrovano a passare nelle vicinanze del Sole. Il calore della nostra stella provoca la sublimazione di parte del ghiaccio che costituisce gran parte del nucleo delle comete. A ogni passaggio ravvicinato le comete perdono quindi una certa quantità della propria massa, disgregandosi più o meno velocemente a seconda dell’entità della minima distanza dal Sole raggiunta e alla frequenza dei passaggi. Le comete di corto periodo si “consumano” quindi più velocemente di quelle con orbite molto ampie che tornano a visitare il sistema solare interno solo dopo secoli o millenni. Le particelle cometarie dapprima si disperdono nelle vicinanze della nucleo e, col passare del tempo si distribuiscono lungo tutta l'orbita. Questi "sciami" di piccoli frammenti, quando lungo la propria orbita intersecano quella terrestre, sono all’origine di molte piogge meteoriche.
Lo sciame meteorico delle Perseidi
Il nome di "Perseidi" è legato alla posizione sulla volta celeste del punto - detto "Radiante" - dal quale paiono provenire le meteore, situato nella costellazione del Perseo. Le “stelle cadenti” che generano le Perseidi sono in realtà residui della disintegrazione progressiva della cometa Swift-Tuttle. Nubi di piccole particelle, scontrandosi a gran velocità con l'atmosfera terrestre, danno luogo a una scia luminosa.
Nell'800 il massimo della loro frequenza avveniva il 10 agosto, giorno della ricorrenza di San Lorenzo, ma ai giorni nostri il massimo si è spostato in avanti di circa due giorni. Le Perseidi sono visibili da metà luglio fino a dopo metà agosto, ma mostrano il maggior numero di meteore dal 10 al 13 agosto, con un culmine che in genere ha luogo il giorno 12, quando la Terra nel suo percorso orbitale intercetta la parte più densa dello sciame di particelle. La possibilità di osservare un maggior numero di Perseidi si ha quando il radiante, nel caso specifico la costellazione del Perseo, è più alto nel cielo, cosa che ad agosto avviene nella seconda parte della notte. In Italia potremo cominciare a osservare il radiante verso le ore 22, dapprima basso sull'orizzonte e quindi via via sempre più alto fino all'alba. Il momento della massima attività dello sciame è prevista quest'anno nelle ore centrali della notte tra il 12 e i 13.
In teoria il massimo numero di meteore sarebbe osservabile nella seconda parte della notte – quando il Perseo si trova ben alto sull’orizzonte. Purtroppo quest’anno la Luna recherà un notevole disturbo. L’eccessiva luminosità del nostro satellite naturale impedirà di percepire le meteore più deboli.
Il giorno di luna piena è il 9 agosto e per tutta la notte il disco lunare rischiarerà la volta celeste. Giorno dopo giorno la Luna sorge un po’ più tardi. Quindi il 12 avremo a disposizione le prime ore della sera prima che la Luna, ormai alta nel cielo, inizi a disturbare le osservazioni delle meteore e degli oggetti meno luminosi della volta celeste. Sulla base di queste considerazioni, possiamo augurarci che le Perseidi 2006 siano, come del resto nei passati anni, numerose e abbastanza luminose, e sperare così di arrivare a osservarne alcune decine, specie nelle due ore centrali della notte.
Per chi prenderà parte alle serate astronomiche la luna stessa sarà comunque oggetto di mirabili osservazioni che al telescopio riveleranno gli spettacolari dettagli dei crateri, delle montagne e dei “mari” selenici.
Consigli utili per osservare le "stelle cadenti"
Il modo migliore per osservare una pioggia meteorica è quello di recarsi in un luogo che abbia una buona trasparenza atmosferica e sia lontano dalle luci artificiali, fuori città, possibilmente in collina o in montagna. Occorre assumere una posizione piuttosto distesa e comoda, esempio su una sedia sdraio, e mantenere lo sguardo verso il cielo. La direzione preferibile verso cui guardare nel caso delle Perseidi è verso est nella prima parte della notte e verso sudest o sud nella seconda metà della notte, circa a metà cielo di altezza.
|
|
09/08/2006
Altri articoli di...
Fuori provincia
04/04/2025
Una serata di emozioni e scoperte (segue)
Una serata di emozioni e scoperte (segue)
14/11/2022
Terremoto: subito prevenzione civile e transizione digitale (segue)
Terremoto: subito prevenzione civile e transizione digitale (segue)
14/11/2022
Il presidente di Bros Manifatture riceve il premio alla carriera "Hall of Fame/Founders Award" (segue)
Il presidente di Bros Manifatture riceve il premio alla carriera "Hall of Fame/Founders Award" (segue)
02/11/2022
Glocal 2022: dove i giovani diventano protagonisti del giornalismo (segue)
Glocal 2022: dove i giovani diventano protagonisti del giornalismo (segue)
02/11/2022
Sisma 2016: approvati 15 mila contributi per 4.8 miliardi (segue)
Sisma 2016: approvati 15 mila contributi per 4.8 miliardi (segue)
27/10/2022
A Cartoceto, nelle ‘fosse dell’abbondanza’ per il rituale d’autunno della sfossatura (segue)
A Cartoceto, nelle ‘fosse dell’abbondanza’ per il rituale d’autunno della sfossatura (segue)
27/10/2022
Il Comune pulisce i fossi Rio Petronilla e via Galilei (segue)
Il Comune pulisce i fossi Rio Petronilla e via Galilei (segue)
27/10/2022
TEDxFermo sorprende a FermHamente (segue)
TEDxFermo sorprende a FermHamente (segue)
ilq


Le strade musicali dell'Ebraismo nel compendio cinematografico di David Krakauer

David Krakauer
"The Big Picture"
Una serata di emozioni e scoperte

ASPIC Psicologia di San Benedetto del Tronto presenta il Centro Psiconutrizionale
Betto Liberati