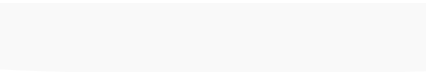Il “dolce” Carnevale marchigiano
San Benedetto del Tronto | Siamo entrati nell’ultima settimana di Carnevale: facciamo un viaggio nella tradizione dolciaria della nostra regione.
di Elvira Apone

le castagnole, tipico dolce marchigiano di Carnevale
Siamo ormai nell’ultima settimana di Carnevale, il periodo in cui viene maggiormente festeggiata questa ricorrenza tipica dei paesi di cultura cattolica. Il termine Carnevale deriva, infatti, dalla locuzione latina carnem levare con cui si intendeva il banchetto che si teneva il martedì grasso, cioè l’ultimo giorno di Carnevale, prima dell’inizio del periodo di digiuno della Quaresima. A questo proposito, le Marche possono vantare una ricca tradizione dolciaria, che si è spesso tramandata di generazione in generazione.
Uno dei dolci marchigiani strettamente legati al periodo di Carnevale sono sicuramente gli scroccafusi, palle di pasta croccante lessate e poi fritte, spolverate di zucchero e bagnate con l’alchermes. Nell’impasto si può anche aggiungere un goccio di Varnelli, il tipico liquore secco all’anice inventato da Antonio Varnelli reinterpretando il tradizionale mistrà marchigiano. Si tratta di un dolce di antica tradizione, legato al mondo contadino. Il nome è onomatopeico, poiché deriva dal verbo scrocchiare, che rimanda al suono che questo dolce dovrebbe produrre sotto i denti nel momento in cui viene mangiato. Una vecchia superstizione narra che se un estraneo entra in cucina mentre qualcuno li sta preparando, questi non riescono bene. In tal caso, però, esisterebbe un rito propiziatorio in base al quale si dovrebbe sputare tre volte a terra e tracciare un segno portafortuna con la scarpa.
Accanto agli scroccafusi non possono mancare le sfrappe o frappe. Sottili strisce di pasta fritte nell’olio e spolverate con zucchero a velo, spesso bagnate anche queste con l’alchermes, sembra che abbiano avuto origine dalla tradizione dei “frictilia” dell’antica Roma, cioè dei dolci fritti nel grasso di maiale preparati proprio durante il periodo del Carnevale.
Anche se migrazioni e contaminazioni hanno influenzato e cambiato diverse ricette popolari, alcune hanno tuttavia resistito immutate nel tempo. Una di queste, sempre legata al Carnevale, è quella delle castagnole, forse il dolce marchigiano più rappresentativo di questa festività. Queste palline fritte, che ricordano i globuli di antica tradizione romana, pur variando leggermente nella forma da zona a zona, richiamano in ogni caso la forma delle castagne da cui prendono il nome. Cosparse anche queste con zucchero o miele o alchermes, possono essere anche farcite con crema o cioccolata.
L’alchermes, liquore di antichissime origini, viene generalmente utilizzato nella realizzazione di parecchi dolci regionali e nasconde un significato atavico legato al suo principale ingrediente: la cocciniglia, un colorante estratto da un insetto parassita già conosciuto in epoca romana e spesso utilizzato nell’industria alimentare. L’usanza di tingere i cibi di rosso è legata agli antichi riti sacrificali: al posto di sacrifici animali talvolta venivano immolati alle divinità cibi colorati di rosso, a simboleggiare proprio il sangue animale. Con il passare del tempo, poi, soprattutto nelle campagne, si è conservata l’usanza di vestirsi o ornarsi di rosso durante le festività, comprese quelle del Carnevale.
Altri due dolci di questo periodo sono gli arancini o limoncini e i ravioli di castagne. I primi sono tipici soprattutto del nord delle Marche. Si tratta di una sfoglia non troppo sottile di pasta lievitata condita con scorza di arancia o di limone e zucchero, arrotolata, fritta, e poi passata nel miele. I secondi sono ravioli ripieni di un impasto dolce a base di castagne e cioccolato, sempre fritti e conditi con zucchero.
Di carattere più nazionale, ma sempre legati alla tradizione carnevalesca della nostra regione sono, invece, le zeppole di patate e la cicerchiata. Morbide ciambelle fritte, le zeppole, soprattutto nell’Italia meridionale, vengono preparate, invece che a Carnevale, il giorno di San Giuseppe, mentre la cicerchiata, che assume nomi diversi da regione a regione, nel sud dell’Italia viene generalmente fatta durante il periodo natalizio. Seppure ne esitano diverse varianti, si tratta sostanzialmente di tante palline di pasta fritte e legate con il miele il cui nome “cicerchiata” quasi certamente deriverebbe dalla cicerchia, un legume tondeggiante simile al pisello e al cece tipico proprio dell’Italia centrale.
In ogni caso, la nostra tradizione dolciaria è frutto di secoli di storia; i nostri dolci, come quelli di ogni regione italiana, sono il chiaro esempio che tradizioni e leggende, se e quando vengono tramandate, riescono a preservare piatti e cibi che, oltre a essere una delizia per il palato, sanno anche raccontarci qualcosa di noi, dei nostri avi e della nostra cultura millenaria.
|
|
01/02/2016
Altri articoli di...
Cultura e Spettacolo
Una serata di emozioni e scoperte (segue)
Il Belvedere dedicato a Don Giuseppe Caselli (segue)
TEDxFermo sorprende a FermHamente (segue)
53 anni di Macerata Jazz (segue)
Il recupero della memoria collettiva (segue)
Giostra della Quintana di Ascoli Piceno (segue)
A RisorgiMarche il Premio "Cultura in Verde" (segue)
Porto San Giorgio torna a gareggiare al Palio dei Comuni (segue)
Fuori provincia
Una serata di emozioni e scoperte (segue)
Terremoto: subito prevenzione civile e transizione digitale (segue)
Il presidente di Bros Manifatture riceve il premio alla carriera "Hall of Fame/Founders Award" (segue)
Glocal 2022: dove i giovani diventano protagonisti del giornalismo (segue)
Sisma 2016: approvati 15 mila contributi per 4.8 miliardi (segue)
A Cartoceto, nelle ‘fosse dell’abbondanza’ per il rituale d’autunno della sfossatura (segue)
Il Comune pulisce i fossi Rio Petronilla e via Galilei (segue)
TEDxFermo sorprende a FermHamente (segue)
Le strade musicali dell'Ebraismo nel compendio cinematografico di David Krakauer

Una serata di emozioni e scoperte

Betto Liberati