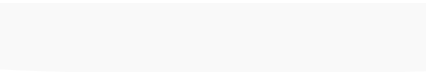LElogio dellindignazione ne Il giorno della Civetta
Fermo | Nel quadro del programma di prosa previsto per la stagione in corso, si sono svolte al teatro delAquila di Fermo le due messinscena dellopera narrativa di Leonardo Sciascia Il giorno della Civetta.
Nella nota in appendice al libro "Il giorno della Civetta", uscito per i tipi dell'Einaudi nel 1963, giallo di assoluta originalità e completamente avulso ai canoni stilistici e narrativi del genere, libero da ogni costrizione temporale e da una rigida costruzione della trama con lo scioglimento finale della vicenda, Sciascia lascia intendere che è stata la letteratura a essersi dovuta fare carico, dopo anni di silenzi e connivenze, di una precisa e severa denuncia del fenomeno mafioso, a bucare ossia, a parte i circostanziati rapporti di studiosi, il muro di ostinata ritrosia, quando non di palese negazione aleggiante attorno ad esso.
Se si escludono due scritti precendenti al suo, entrambi destinati al teatro (l'uno in dialetto siciliano intitolato "I mafiusi de la Vicaria" di Giuseppe Rizzotto e Gaspare Mosca, l'altro in italiano, di Giuseppe Alfredo Cesareo e conosciuto con il titolo di "Mafia"), nessun altro letterato in Sicilia aveva mai osato affrontare apertamente, prima degli anni Sessanta la rete di contiguità, omertà, favori, insomma quella stratificazione di atteggiamenti ed abitudini, quel "sentire mafioso", che aveva favorito e protetto, con il tempo, l'insorgenza prima ed il radicamento poi nell'ambito della società siciliana di una realtà criminale talmente subdola da risultare quasi invisibile agli occhi della gente o da venire abilmente nascosto dietro uno strato di ipocrisie borghesi.
Più che un racconto giallo, la vicenda rappresentata da Sciascia è un'impietosa e dura indagine sulle ramificazioni filiformi assunte dalla Mafia nel corpo civile del paese e l'ambientazione, del resto scarna, allusiva, filiforme, è solo un pretesto per prefigurare un desolato paesaggio dell'anima, una Sicilia trasfigurata (lo denuncia l'anonimato delle località presentate nel libro espresse con le sole iniziali) in una dimensione del Male che può insinuarsi facilmente in ognuno di noi se non si dispone degli anti-corpi necessari per arginarlo, dove gli stessi personaggi sono proiezioni allegoriche di una dimensione universale in cui a fronte di un potere che abusa e schiaccia pochi hanno il coraggio di levarsi in segno di protesta.
Sciascia ci ricorda il più bel moralismo francese del Settecento (da La Bruyère a La Rochefoucald) ovvero di quegli scrittori, che, attraverso uno stile secco, disadorno, bruciante, ma non meno venato di coloriture (per Sciascia un parlato regionale impastato a tratti con il vernacolo), seppero mettere a nudo le ipocrisie umane e tutto il vermicaio di sentimenti contradditori e insani vizi che si cela dietro la normalità di una vita apparentemente rispettabile.
Perché la crescita della Mafia è nella compressione del nostro spazio di libertà, nella rinuncia ad una presa di coscienza civile, nella mancanza di forza delle nostre idee (quel limbo insensibile e pervadente in cui Sciascia fa ricadere lo stato di passività dei siciliani nei confronti della criminalità e delle sue derivazioni politico-imprenditoriali da quando, subito dopo la guerra, si districò dall'intelaiatura di un'arcaica struttura patriarcale, profondamente legata al territorio, per assumere il volto aggressivo, cinico ed impertinente di una temibile compagine manageriale pronta a macinare profitti illeciti ed allacciare legami con una parte compromessa della classe dirigente ed affaristica italiana).
Il fatto realmente accaduto di cui si tratta nel libro (ovvero l'assassinio di un sindacalista nella Sicilia della fine degli anni Cinquanta sul quale si staglia l'inchiesta condotta da un capitano dei carabinieri proveniente da Parma, emblema della cosiddetta "tranquilla" provincia italiana) è una corsa ostacoli verso la ricerca della verità, continuamente misconosciuta, elusa, vilipesa dal sopruso ricorrente, dall'ignavia irredimibile, dalla pusillanimità comprata o indotta dei vari personaggi tipici di una terra che mescola nel suo seno, indifferentemente, carnefici e vittime, eroi e mediocri, "uomini e non" in un tragico, atavico teatro della passioni umane.
Così il parmense commissario Bellodi del racconto, venuto dal Nord per "sconfiggere" la Mafia ed intenzionato a raccogliere elementi di prova sufficienti per incastrare mandanti ed esecutori dell'uccisione del modesto impresario edile, Nicola Colasberna e portato sulla traccia giusta da un ambiguo confidente dei carabinieri, tale Calogero Dibella detto Parrnieddu, si trova nel finale a confrontarsi, in una memorabile pagina del romanzo, con Don Mariano Arena, "gentiluomo" dalle amicizie altolocate e dall'arcana, sbrigativa sagacia.
Egli riconosce nel commissario imperturbabilmente fedele ai suoi compiti, moralmente integerrimo, dallo sferzante pragmatismo, un "uomo", mentre nella massa che non sa decidersi ad un'azione, che non esprime giudizi, che non si rende artefice del suo destino, ma è al contrario materia friabile e docile nelle sue stesse mani, un concentrato di "ominicchi, pigliainculo e quaquaraquà".
In mezzo a tale coacervo di eventi si collocano l'uccisione e l'occultamento del cadavere di Paolo Nicolosi, testimone scomodo dell'omicidio, la figura di sua moglie, Rosa, schierata a fianco di Bellodi nell'accertamento dei fatti e decisiva nel ricondurre l'inquirente sulle tracce del sicario Diego Marchia, dalla fedina penale sporchissima e di Rosario Pizzico, mandante dei due delitti per spirito di rivalsa nei confronti del Colasberna, e la delazione, anch'essa preziosa, resa, poco prima di morire, anch'egli assassinato, da Calogero Dibella.
Poi, nel finale, la ricomposizione della storia attorno all'acquietamento della situazione con lo smantellamento dell'appartato accusatorio a seguito della rete di protezioni costruita attorno al Marchica da uomini politici intenzionati a mantenere i loro privilegi, il trasferimento del maresciallo Ferlisi, la licenza comminata al Commissario Bellodi e la fuga della candida Rosa.
Tutto sembrerebbe affrettare la sconfitta della giustizia come bene intangile, di un indomito spirito di onestà intellettuale e di un doveroso impegno civile, se non fosse per le parole pronunciate alla fine del libro dal protagonista: "...Ma prima di arrivare a casa sapeva, lucidamente, di amare la Sicilia e che ci sarebbe tornato. "Mi ci romperò la testa" disse a voce alta".
Lucida, appassionata, sottilmente polemica, disarmante ed aspra nella sua analisi, la rappresentazione teatrale di Fabrizio Catalano Sciascia, sapientemente costruita su un duplice piano narrativo reso dalla destrutturazione della scena in due livelli sovrapposti, restituisce in pieno la fragranza del "j'accuse" del nonno Leonardo proprio nell'essenziale significatività dell'ambientazione e nei toni struggentemente drammatici di un Sebastiano Somma, ad esempio, completamente calato nella sua parte, suggerendo nel pubblico un interrogativo insoddisfatto e lasciandolo, in un ultima istanza, solo con un moto di rabbia ed un malcelato senso di indignazione contro il gioco perverso dei poteri che da sempre tiene in scacco l'Italia, contro i silenzi di una società assuefatta o intimidita, contro una letteratura per molto tempo agiografica ed indulgente che ha così scarsamente sentito il bisogno di rivoltarsi di fronte al dilagare della violenza mafiosa, contro le critiche, che, anche da morto, Sciascia ha dovuto subire per il suo indomito coraggio di acuto polemista e che ci fanno gridare assieme a lui: "non ci avrete maledetti!"
|
|
17/02/2011
Altri articoli di...
Cultura e Spettacolo
Una serata di emozioni e scoperte (segue)
Il Belvedere dedicato a Don Giuseppe Caselli (segue)
TEDxFermo sorprende a FermHamente (segue)
53 anni di Macerata Jazz (segue)
Il recupero della memoria collettiva (segue)
Giostra della Quintana di Ascoli Piceno (segue)
A RisorgiMarche il Premio "Cultura in Verde" (segue)
Porto San Giorgio torna a gareggiare al Palio dei Comuni (segue)
Fuori provincia
Una serata di emozioni e scoperte (segue)
Terremoto: subito prevenzione civile e transizione digitale (segue)
Il presidente di Bros Manifatture riceve il premio alla carriera "Hall of Fame/Founders Award" (segue)
Glocal 2022: dove i giovani diventano protagonisti del giornalismo (segue)
Sisma 2016: approvati 15 mila contributi per 4.8 miliardi (segue)
A Cartoceto, nelle ‘fosse dell’abbondanza’ per il rituale d’autunno della sfossatura (segue)
Il Comune pulisce i fossi Rio Petronilla e via Galilei (segue)
TEDxFermo sorprende a FermHamente (segue)
Le strade musicali dell'Ebraismo nel compendio cinematografico di David Krakauer

Una serata di emozioni e scoperte

Betto Liberati