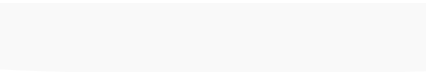Gli esami di una volta
| Ai miei tempi l'esame di maturità non comportava una simile preparazione: non per niente, oggi, siamo europei, che diamine!-.
di emme
Ho sottocchio le immancabili cronache giornalistiche : le " tracce" e gli umori degli affaticati maturandi, i tormentati commenti di un evento epocale che si concluderà con promozioni in percentuali " bulgare" e lo sdegno e l'urlo di anime svuotate perché gli han tolto il ' telefonino', haimé!. Non voglio parlare né delle " tracce", né del perché di un esame che non ha più alcun senso: sarebbe come sparare sulla Croce Rossa.
Non voglio nemmeno cadere nel tòpos " Ai-miei-tempi- l'esame- di maturità
" ( conoscete il seguito
) nel quale annaspano le generazioni, una dopo l'altra, in preda a frenesia mitopoietica che retrocedendo nel tempo, ingigantisce in maniera esponenziale difficoltà e studiose fatiche nella gran calura estiva di una volta
( " Si è vero, quest'anno fa un po' caldo, ma quando io detti gli esami di maturità
" esordisce il settantenne, mentre i vispi nipoti fuggono ).
Mi domando, invece, chi siano questi ragazzi cui la Scuola dà una certificazione di " maturità", come si fa con le pere e la frutta esotica. Mi domando che cosa gli abbia dato la Scuola e che cosa portino di nuovo a noi, gente omologata, globalizzata, scettica, opportunista, per lo più soddisfatta, cui la vita ha spento gli ideali ma ha dato reti televisive e beni di consumo a iosa, tanto che non c'è più tempo per pensare ed altri, del resto, pensano per noi.
Difficile dare una risposta. Tentiamo con " I giovani sono le speranze dell'umanità", oppure " I giovani sono l'avvenire". Quest'ultimo assioma si può sempre enunciare con gravità e senza rischi, visto che è sorretto dall'oggettività anagrafica. Ci sarà poi gente cavillosa che dice che l'avvenire è inconoscibile e, quindi, sono inconoscibili anche i giovani, per cui non è una risposta alla domanda principale. Proviamo con il primo. " Speranze dell'umanità", suona bene e riempie la bocca più di un cucchiaio di caviale Beluga, ma qualcuno scuote il capo e mormora " vuota retorica!" e vuol sapere di quali speranze concrete e specifiche si parla e chi, come, quando le ha inoculate nei giovani cuori e nelle vergini menti. Un po' come chiedere alla Ministra della Pubblica Istruzione che dice di aver voluto propinare ai giovani maturandi " i valori", di tradurre, specificare, esemplificare e farci capire di che sta parlando.
Sarà per caso che nelle " tracce" di questi esami si ripeta frequentemente l'invito ad una riflessione sull'opera di Pirandello, genio nevrotico e nichilista?- Ma forse è il frutto avvelenato di una intuizione disperata di intelletti ministeriali. Resta il dubbio, quando non si riesce a 'comunicare' ( non illudetevi, signori professori! ) con questi giovani, chi ci sia dentro la giara: noi o loro? Facendo ricorso a quel po' di filosofia che m'avanza dagli anni del Liceo, credo che non lo sapremo mai. Forse gli uomini, quale che ne sia l'età, entrano ed escono a piacimento e secondo necessità, dalla giara che si cuciono intorno. Forse il mondo dentro la giara è uguale all'infinito mondo di fuori , forse Scegliete voi la risposta, perché così è se vi pare. Del resto, immaginare i giovani come futuri riparatori di cocci infranti, è una risposta che non mi dispiace.
Naturalmente gli strumenti necessari a questo lavoro di riparazione, glie li ha dati, per lo più, la scuola. Si sa che nessun artigiano può essere un bravo artigiano se non dispone degli strumenti adatti. La Scuola ha assolto a questo compito?- Nel nostro Paese, dal 1861 in poi, programmi scolastici, libri di testo
" unici", preparazione dei docenti furono organicamente predisposti e formati per " fare gli Italiani", conducendo per mano i giovani a visitare le mitiche " origini" e il "riscatto" risorgimentale, oleografico e sabaudo e da quelle traendo gli exempla sui quali conformare il loro comportamento sociale. Di qui la preminenza degli studi classici ed umanistici e la funzione propriamente
" educativa" della Suola di Stato.
L'ultima guerra, la caduta di un regime che taluno vuole in continuità con precise tendenze politiche ottocentesche, l'apertura al mondo di fuori, hanno determinato la crisi della Scuola e la ricerca,.non ancora conclusa, di contenuti dell'insegnamento. Definire, oggi, quale sia il rapporto discente-Scuola e, di conseguenza, quale sia il patrimonio culturale che quest'ultima consegna al primo, è difficile dire. Si naviga in un mare di assiomi, presunzioni, previsioni, vanterie, reticenze, disomogeneità culturale, trovate ministeriali e funeste psicologicherie.
Di certo e tangibile c'è il disagio del mondo giovanile, l'incertezza, il relativismo fatto elastica norma morale, il contrasto fra i naturali, generosi orizzonti giovanili e quell'immediato benessere che sembra a portata di mano e conclude l'avventura prima che sia iniziata. Ma, basta con le divagazioni e torniamo agli esami di maturità.
Certo, deve essere stata dura. Immaginate quante lezioni, e che fatica!, apprendere il ciclo dell'acqua, le quantità variamente distribuite, il rapporto con i consumi ( santo Iddio! Non vi basta una doccia al giorno!
) e le perdite degli acquedotti, i costi della distribuzione, la storia del prezioso elemento, la letteratura connessa (
Can lo rius de la fontana s'esclargis , si cum far sol
,- sorella acqua,- chiare, fresche , dolci acque,- piove sulle tue ciglia brune,- gli excerpta berlusconiani
etc.etc.), la trasformazione in corso dei Consorzi idrici in società per azioni, la privatizzazione prossima degli stessi ( l'affare del millennio. A quando la privatizzazione dell'aria di montagna? ).
Tutte nozioni senza le quali quel tema nessuno lo avrebbe potuto svolgere. Tradurre Seneca, poi
! La Scuola avrà certamente elargito ogni conoscenza su questo ambiguo, quanto attuale, personaggio, severo filosofo e moralista, statista del quinquennium neronis, l'uomo più ricco di Roma ( ognuno ha la sua croce, anche i filosofi
). Che lezione discende poi da quella traccia dove, nel corpo di una citazione letterale, la parola
" tangentopoli" è stata sostituita con puntini, puntini!.
Ai miei tempi l'esame di maturità non comportava una simile preparazione: non per niente, oggi, siamo europei, che diamine!-. Mi dispiace, perché è scrittore raffinatissimo che amo, ma devo dar torto a Pietro Citati ( " La Repubblica" 20 giugno, pgg. I e 16 ): questi esami son da mantenere, questa Scuola è mirabile, questi giovani hanno avuto una preparazione tale che renderà loro facile sconfiggere la vita globalizzata, consumistica, consacrata all'avere ed all'apparire che gli lasciamo in eredità.
|
|
21/06/2003
Altri articoli di...
Le strade musicali dell'Ebraismo nel compendio cinematografico di David Krakauer

Una serata di emozioni e scoperte

Betto Liberati